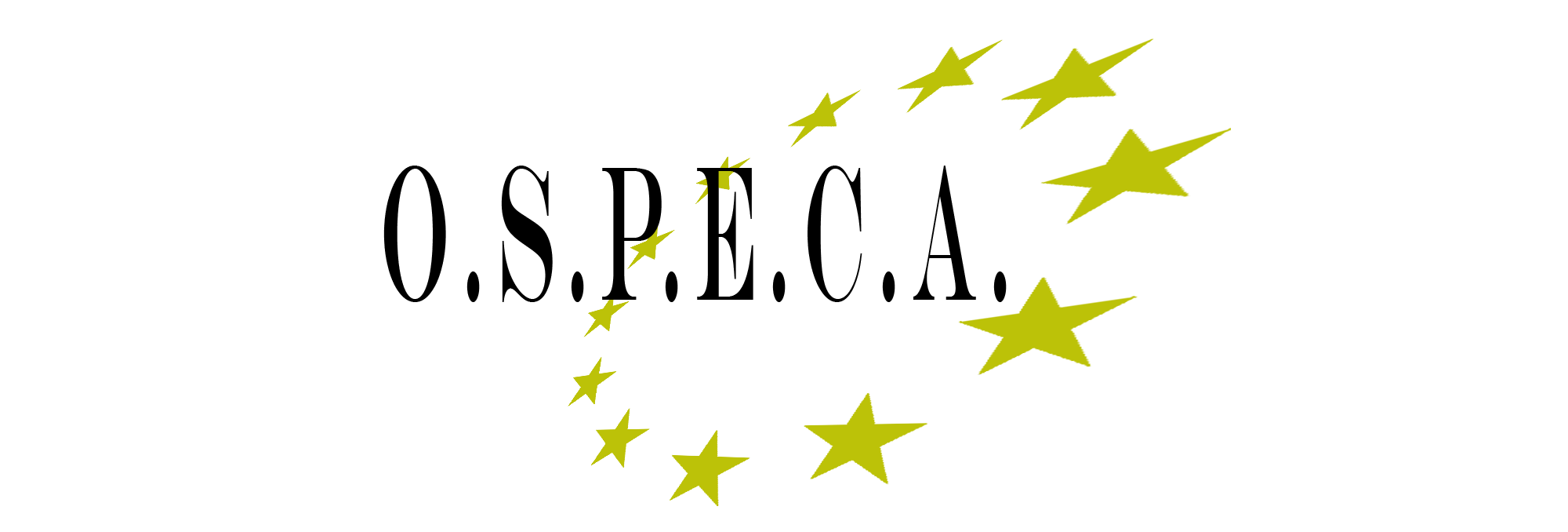Celebre economista inglese nato a Londra nel 1772 morì nel 1823, David Ricardo è uno dei massimi esponenti della scuola classica. Figlio di un banchiere ebreo, accumulò una considerevole fortuna prima come agente di cambio, poi come banchiere e, nel 1819, venne eletto alla camera dei comuni.
Si possono distinguere due tappe successive nello sviluppo del pensiero di questo economista classico, la prima delle quali inverosimilmente esordisce, secondo tale congettura, nel 1814, con un appunto sui “profitti del capitale”, andato perduto, e si conclude con il Saggio sull’influenza del basso prezzo del grano sui profitti, pubblicato nel 1815. Ad essa segue la seconda tappa che ha inizio con la critiche di Malthus al “modello del grano”, e si conclude con la redazione dell’opera Sui principi dell’economia politica e della tassazione del 1817, nonostante Ricardo abbia continuato a riflettere sui diversi aspetti del problema sino agli ultimi giorni della sua vita.
Si può affermare che la “tesi fondamentale” sulla quale Ricardo concentrò la sua analisi, la quale, in estrema sintesi, individua il limite alle possibilità dello sviluppo capitalistico nella scarsità e nei rendimenti decrescenti delle terre fertili, disponibili per la produzione di alimenti. La crescita della popolazione, stimolata dall’accumulazione del capitale, induce la coltivazione di terreni via via meno fertili, causando a sua volta una caduta del saggio di profitto. Ma poiché il livello del saggio di profitto è proporzionale al tasso di accumulazione del capitale essendo pari, per definizione, al rapporto tra profitti e capitale anticipato, questo processo produce l’effetto di un graduale rallentamento del processo di sviluppo stesso, fino al raggiungimento dello stato stazionario.
Per l’importante ruolo svolto dalla determinazione del saggio di profitto nel regolare il funzionamento concorrenziale dell’economia capitalistica, nonché nel processo di sviluppo economico, essa costituì un aspetto centrale della costruzione analitica di Ricardo e per la stessa venne avvertita dall’ autore la necessità di un’analisi del valore di scambio che spiegasse adeguatamente la formazione dei prezzi delle merci.
Il problema del valore, dunque, iniziò ad esser oggetto di studi approfonditi da parte di Ricardo dopo la pubblicazione del Saggio sull’influenza del basso prezzo del grano sui profitti, ed, in particolare, successivamente alla critica mossa da Malthus all’intera argomentazione ivi espressa nella quale Ricardo, ai fini della determinazione del saggio di profitto autonomo rispetto alla variazione dei prezzi, aveva espresso le sue due componenti, – capitale anticipato e profitti – in termini di quantità fisiche di una stessa merce, il grano, in modo da essere omogenee tra loro e da poterne calcolare il rapporto, aggirando peraltro il problema sorto nel determinare il valore dei prezzi relativi dei beni che entrassero nel capitale anticipato e nel sovrappiù, per poi poter calcolare il valore dei profitti e del capitale anticipato, e quindi il saggio di profitto.
Il passaggio dal Saggio sull’influenza del basso prezzo del grano sui profitti ai Principi di Economia politica può essere facilmente compreso se si tiene conto degli obiettivi teorici che Ricardo si propose di raggiungere nella prima opera e delle difficoltà analitiche in cui incorse. In dettaglio, il primo obiettivo consisteva nell’illustrare i vantaggi che l’intera nazione avrebbe conseguito in seguito ad un’eliminazione delle restrizioni legali all’importazione di grano; il secondo consisteva nella dimostrazione che il profitto e la rendita erano, nell’ipotesi di un livello salariale costante, forme di reddito antagoniste: con il procedere dell’accumulazione del capitale, a causa dei rendimenti decrescenti della produttività del lavoro agricolo, il saggio di profitto era infatti condannato alla diminuzione in favore di una crescita continua delle rendite. Orbene, in entrambi i casi, si trattava di dimostrare che l’aumento del prezzo del grano derivante da dazi all’importazione o da difficoltà nella produzione agricola, causasse dei danni irreparabili al processo di sviluppo e che, viceversa, i profitti generali del capitale potevano essere aumentati solo da una diminuzione nel valore di scambio dei viveri, la quale avrebbe potuto derivare o da una riduzione dei salari reali, il che avrebbe senz’altro messo l’agricoltura in grado di portare al mercato una maggiore eccedenza del prodotto, oppure dall’introduzione di innovazioni tecnologiche in termini di attrezzi o di tecniche che avrebbero consentito anch’essi un aumento quantitativo del prodotto, o ancora dalla scoperta di nuovi mercati, da cui il grano poteva essere importato ad un prezzo minore rispetto a quello a cui poteva esser coltivato all’interno.
Malthus ritenne che l’utilizzo del grano come unità di misura al fine di ottenere grandezze omogenee rappresentasse un’ipotesi tanto irreale quanto impraticabile perché il capitale ha una composizione merceologica differente da quella del prodotto, dal momento che in ogni processo produttivo si utilizzano mezzi di produzione eterogenei tra loro rispetto ad esso. Il profitto doveva dunque necessariamente scaturire da un confronto tra valori e non da una comparazione tra aggregati di prodotti e tale circostanza aveva peraltro degli effetti non trascurabili sul saggio generale di profitto.
Ricardo non sottovalutò tali critiche e iniziò ad affrontare il problema del valore e dei prezzi in una prospettiva più generale, attraverso la stesura dell’opera intitolata Sui principi dell’economia politica e della tassazione la cui prima edizione fu pubblicata nel 1817 e nel cui primo capitolo espose la sua teoria del valore-lavoro sostituendo il lavoro al grano come grandezza nei cui termini esprimere il prodotto, il salario e il surplus. All’interno di questa rielaborazione concettuale il profitto venne concepito come differenza residua tra la quantità di lavoro necessario a produrre i mezzi di sussistenza della forza lavoro e la forza-lavoro complessiva, dipendente «dalla proporzione del lavoro annuale del Paese…volta al mantenimento dei lavoratori. In termini di valore, la tesi che i profitti cadano a causa della decrescente produttività del lavoro, espresso in grano, si traduce nella forma secondo cui i profitti cadono a causa dell’aumento del valore del grano, e dunque del salario, in rapporto ad altri prodotti.
Nel percorso di analisi del problema del valore, Ricardo accettò la distinzione smithiana tra valore d’uso e valore di scambio, rifiutando il primo come «misura del valore di scambio, sebbene sia assolutamente essenziale a tale valore» e approfondendo il secondo con maggior rigore.
Tuttavia, rimproverò a Smith il fatto che nella sua teoria non fosse rinvenibile un univoco termine misurativo del valore di scambio delle merci e che fosse caduto in errore distinguendo la causa del valore dalla misura del valore stesso. In particolare, Smith distinse tra lavoro contenuto, inteso come unità di misura del valore di scambio nella società pre-capitalistica in cui il lavoratore era anche proprietario dei mezzi di produzione nonché del prodotto del suo lavoro, contraddistinguendosi dunque per la corrispondenza tra causa del valore e misura del valore, dal lavoro comandato, definibile invece come espressione misurativa del valore di scambio nella società capitalistica, caratterizzata dall’accumulazione del capitale, dalla privatizzazione della terra e dal lavoro salariato in cui causa del valore e misura del valore non corrispondono perché, pur rimanendo il lavoro incorporato la causa del valore di scambio, la necessità di remunerare non soltanto il lavoro ma anche gli altri due fattori produttivi – terra e capitale – rendeva necessaria una misura del valore con un’unità di conto diversa, rappresentata dalla quantità di lavoro che ciascuna merce comanda sul mercato. Così, secondo Smith, in un’economia capitalistica ogni merce aveva un prezzo naturale dato dalla somma dei saggi naturali del salario, del profitto e della rendita e questa somma comandava una quantità di lavoro maggiore di quella incorporata3. Questa conclusione per Ricardo era viziata da due errori logici. In primo luogo, se i valori di scambio fossero stati misurati dalla quantità di lavoro che ciascuna merce poteva comprare sul mercato si sarebbe misurato il valore di scambio di una merce con un altro valore di scambio del lavoro, il salario. Sarebbe, in tal caso, rimasto aperto il problema della determinazione di che cosa a sua volta misurava il salario, cioè il valore del lavoro. Il secondo errore logico scaturiva dalla seguente circostanza: ogni merce, seguendo Smith, era prodotta con una quantità data di lavoro incorporato. Il capitalista acquistava questa quantità di lavoro al saggio naturale di salario, e sulla somma erogata calcolava il saggio naturale di profitto. In tal modo, facendo astrazione dalla rendita, perveniva al prezzo naturale di vendita. Poiché il saggio naturale del profitto era calcolato dai capitalisti in proporzione alla quantità di lavoro acquistata, era solo quest’ultima quantità a determinare il rapporto di scambio fra due merci e non certo l’ammontare del saggio di profitto, per cui la causa dei valori relativi doveva necessariamente coincidere con la loro misura, anche se il ricavato della vendita dei beni non andava per intero ai lavoratori. In conclusione, allora, Ricardo riscontrò che anche nella società capitalistica ciò che faceva variare il valore di scambio di ogni merce era unicamente il lavoro contenuto, perché la maniera in cui il ricavo di vendita di una data merce veniva di volta in volta diviso tra le principali classi sociali non implicava alcuna variazione nel valore relativo della merce stessa.
L’analisi della distribuzione dei redditi servì a Ricardo per formulare una teoria “pessimistica” dello sviluppo economico capitalistico. Posta come condizione allo sviluppo stesso l’esistenza di un saggio di profitto sufficientemente elevato da permettere un’adeguata accumulazione di capitale e quindi un aumento della produzione, l’economista inglese rilevò che la tendenza del saggio di profitto a diminuire, in quanto la necessità di coltivare terre sempre meno fertili in seguito allo sviluppo demografico avrebbe determinato da una parte un aumento della rendita e dall’altra un aumento del prezzo delle derrate alimentari e quindi dei salari correnti, avrebbe frenato lo sviluppo economico.
Di notevole importanza sono anche i contributi di Ricardo alla teoria del commercio internazionale e alla teoria monetaria. In sostanza, Ricardo, pur condividendo i princìpi liberistici di Adam Smith, non ritiene che la legge della domanda e dell’offerta possa condurre ad un’equa redistribuzione della ricchezza: a tal proposito, Ricardo individua due fattori di squilibrio. Il primo è dato dal rapporto tra la rendita fondiaria, cioè il reddito prodotto dalla proprietà della terra, e la crescita demografica. Per sfamare la popolazione sarà necessario coltivare anche i terreni meno fertili, con maggiori costi di lavoro e una minore rendita. Poiché la popolazione crescerà sempre di più, sarà sempre più vasto il ricorso a terreni sempre meno fertili con rendite sempre più basse. Per questa via la “rendita differenziale”, ovvero la differenza tra la rendita dei terreni più fertili e quella dei terreni meno fertili diverrà sempre più grande. Il secondo fattore di squilibrio economico/sociale è dato dalla cosiddetta legge ferrea dei salari, secondo la quale, in base alla legge della domanda e dell’offerta, i salari tendono ad abbassarsi sempre più, per attestarsi al mero limite di sopravvivenza del lavoratore.