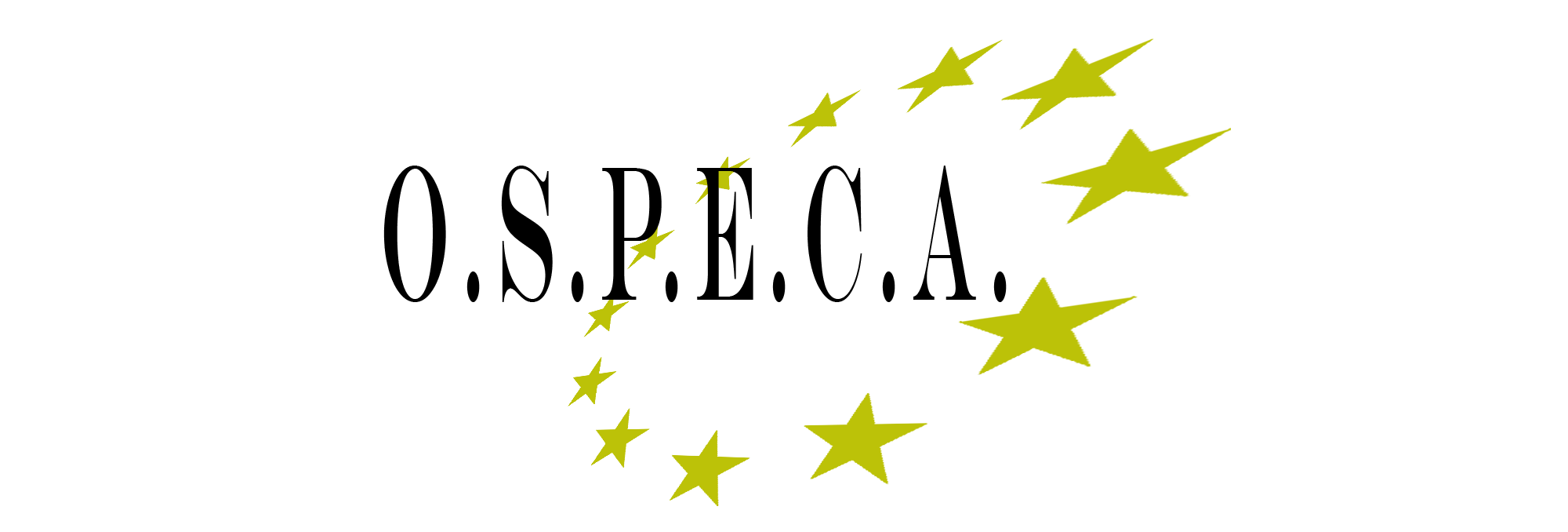La crisi economica argentina, a cavallo tra gli anni Novanta e il Duemila, radica le sue radici negli anni Settanta e Ottanta.
Durante questo periodo storico la nazione era governata da giunte militari risalenti al peronismo. Come capita molte con questi regimi al potere, furono attuate politiche nazionalistiche e protezionistiche tra le quali la guerra delle Falkland e l’acquisizione statale del sempre crescente debito privato. Così facendo nel 1983 si ebbe l’esplosione del debito pubblico, basti pensare che il servizio del debito estero ammontava a 142 miliardi di dollari. Le difficoltà economiche aumentarono per via della disoccupazione stimata dal governo intorno al 5% ma che, in realtà, era di circa il 18%.
Questo è un esempio di come, nonostante il trascorrere del tempo e l’avvicendarsi di governi di diversa estrazione politica, le stime macroeconomiche elaborate in Argentina spesso sottovalutano i problemi. Se tra il 1976 e il 1983 si mentì sul tasso di disoccupazione, attualmente possiamo osservare come viene nascosto il valore reale dell’inflazione (22,8% nel 2013 e stimata attorno al 38% nel 2014, a fronte di stime governative del 10,6%).
Nel 1983, con il ritorno della democrazia a seguito della disfatta subita nella suddetta guerra, salì al governo Alfonsin che creò una nuova moneta nazionale, l’austral. Questa misura aggravò un ulteriore indebitamento e, quando il rimborso degli interessi non fu più possibile, la fiducia nella nuova valuta crollò portando l’inflazione dal 10-20% al 5.000% annuo del 1989. La disoccupazione non scese di molto ma i salari reali si dimezzarono
Nello stesso anno Alfonsin si dimise a seguito della forte pressione popolare e fu sostituito da Menem. La sua lotta contro l’inflazione ebbe i suoi effetti e nel 1992 si pose il cambio fisso di 1 peso (ripristinata dopo l’esperienza negativa dell’austral) per 1 dollaro. Nei primi anni la stabilità dei prezzi migliorò la qualità della vita, favorì le importazioni e l’accesso al credito ma, successivamente, la perdita di competitività determinò la fuga dei capitali verso l’estero e la deindustrializzazione. Nel frattempo corruzione e spesa pubblica, trainata dal costo del debito, non smettevano di aumentare.
Perciò quando, nel 1995, il dollaro si rivalutò nei confronti di yen e marco e crebbe l’euforia dei mercati per la prossima creazione di una moneta europea unica la posizione internazionale dell’Argentina s’indebolì anche per via dell’erosione delle riserve valutarie.
Inoltre furono manifesti i problemi strutturali di un cambio fisso alla pari con il dollaro: l’economia reale argentina si fondava sull’esportazione di materie prime mentre quella americana cresceva esponenzialmente grazie al settore tecnologico. D’altra parte il volume di affari americano era di quaranta volte superiore a quello argentino.
La disoccupazione crebbe, il PIL incominciò a scendere, il proliferare di forme di liquidità parallele e la politica restrittiva del governo de la Rua portarono alla sfiducia dei mercati nei confronti dell’Argentina.
Ci fu un’ingente ed improvvisa conversione del peso in dollaro e la successiva fuga di capitali verso i paradisi fiscali. Ne conseguì la corsa agli sportelli contrastata dal governo con il congelamento quasi integrale dei depositi in banca. Questo limite ai prelievi colpì fortemente il ceto medio-basso (nel 2002 il 55% della popolazione era sotto la soglia di povertà e il 27% viveva in una situazione di povertà estrema).
Nel frattempo il debito pubblico continuava a crescere per via degli alti tassi d’interesse dovuti per il rischio, sempre più concreto, d’insolvenza.
E così fu. L’ultima settimana del 2001 vide il governo argentino annunciare lo stato di default per la maggior parte del debito pubblico in scadenza, di circa 132 miliardi di dollari, congelando il pagamento degli interessi e sospendendo il rimborso dei capitali.
Le ripercussioni al di fuori dell’Argentina riguardarono per lo più coloro che avevano i bond del debito. I 450.000 risparmiatori italiani (per 14,5 miliardi di dollari) si riunirono nella Task Force Argentina che davanti all’ICSID (International Centre for Settlement of Investment Disputes, un tribunale internazionale per le dispute fra Stati ed investitori esteri) agì contro lo Stato sudamericano.
Una prima soluzione, fortemente voluta dal FMI, era quello di riconvertire i titoli scaduti con nuovi titoli a scadenza trentennale per una perdita complessiva del valore di rimborso atteso del 70% circa. All’estero l’iniziativa riscosse un discreto successo, più contenuto in Italia dove si preferì agire contro le banche italiane e gli istituti finanziari.
Alla fine dei processi è stato rimborsato circa l’85% del valore nominale ma ancora 50.000 attendono. E proprio a fine giugno è prevista la scadenza.
OSPECA
MAURO MARTINO